Quando incontri una storia speciale, te ne accorgi subito. L’aria si sospende, il battito rallenta, lo sguarda prova ad andare oltre e si sincronizza anche il respiro. La storia di una donna e una mamma in rinascita, un dono per me e per chi vorrà leggere con il cuore.

Disegni di Michal Rovner. Tratto dal libro L’abbraccio di Grossman D., edito da Mondadori, 2010
Sono diventata mamma per la prima volta nel 2012, dopo un anno di tentativi falliti e altrettanti pianti silenziosi all’arrivo di ogni ciclo. Un anno difficile, contrassegnato dalla solitudine: marito lontano per lavoro e lavoro sfrenato in ufficio per compensare i vuoti. Immaginavo l’arrivo di un figlio come un momento magico, capace di spazzare via la tristezza e rigenerare un rapporto vissuto a distanza. Nel dormiveglia immaginavo di stringere forte il mio piccolo e di allattarlo. Era il mio ultimo pensiero ogni sera prima di addormentarmi. Rimasi incinta quando ormai avevo perso la speranza ed ero pronta a preparare la domanda per l’adozione, quando smisi di fare calcoli sui giorni fertili, quando un ginecologo mi disse che avrei dovuto fare accertamenti a causa dei miei follicoli troppo grossi ed iniziare una cura ormonale. Il primo mese di gravidanza fu bellissimo, mi sembrava di camminare sospesa da terra, era tutto perfetto come avevo immaginato nel buio della mia camera da letto. Il sogno fu bruscamente interrotto da una macchia di sangue che si trasformò in un flusso vero e proprio nel giro di pochi minuti. Ricordo ancora come se fosse oggi la disperazione durante la corsa in ospedale, con la certezza di aver perso quel bimbo tanto desiderato. Distesa su un lettino freddo, con le lacrime che mi offuscavano la vista, un medico poco cortese mi disse di smettere di piangere perché il bimbo stava bene, di fare punture e stare a letto finché le perdite di sangue non si fossero fermate. Di colpo mi ritrovai a vivere h24 tra letto e divano, con la paura che anche un piccolo movimento avrebbe potuto far male al miracolo che stava crescendo dentro di me. Piano piano cominciai a spegnermi. Il sollievo di essere ancora incinta lasciò presto spazio al nervosismo e alla tristezza. Cominciai a piangere senza sapere bene quale fosse il motivo. Mi sentivo sola e incompresa ma non lo davo a vedere, nascondendomi tutti i giorni dietro un sorriso di circostanza per amici e parenti. Passai quasi tutta la gravidanza a letto, con l’ansia perenne che qualcosa potesse andare storto. Il giorno tanto atteso arrivò nonostante tutto. Dopo tre giorni di travaglio ed un parto tremendo,l’angelo dagli occhi color caffè che tante volte avevo immaginato fece ingresso nella mia vita. Sembrava tutto perfetto, forse troppo. Faceva tanto caldo in quei giorni, troppo caldo per un bimbo di pochi giorni digiuno. Il piccolo ciucciava con tutte le sue forze ma la montata lattea tardava ad arrivare. La mia inesperienza e la presenza attorno a me di persone inesperte non mi permisero di capire che qualcosa non andava e il mio angelo svenne in auto mentre stavamo andando in ospedale per un controllo, dopo aver trovato tracce rosse nel pannolino. In quei 10 interminabili minuti pensai che fosse morto. Si svegliò all’arrivo in tin dove lo portai attraversando di corsa lunghi corridoi, senza neanche sentire il dolore degli innumerevoli punti del parto e la stanchezza di quei lunghi giorni senza sonno. In quei 10 minuti il terrore si impadronì della mia mente e non fui lucida neanche con i medici che all’inizio non capirono, scambiandomi per una neonamma ansiosa. Mi chiesero scusa goffamente dopo molte ore, dicendomi che in effetti il bimbo aveva avuto un calo glicemico che aveva causato lo svenimento. Tornai a casa distrutta e arrabbiata. Arrabbiata con i medici e con me stessa per non aver capito che il mio bimbo non stava bene. Il giorno dopo arrivò il latte ma dopo le prime poppate cominciai a sentirmi stanca, eccessivamente stanca. Nel pomeriggio cominciai ad avere la sensazione che il mio corpo stesse cedendo, non avevo la forza di muovermi, mi sentivo paralizzata. Arrivò a casa il 118 che mi portò in ospedale. Ero lucida ma non riuscivo a muovermi. Ad un certo punto le forze mi abbandonarono quasi del tutto, il mio corpo non rispondeva più. Dissi a mio marito che stavo per morire, lo salutai, raccomandandogli di prendersi cura del nostro cucciolo e mi addormentai o forse svenni. Dopo tante ore mi dissero che avevo l’emoglobina bassa e mi parcheggiarono in una barella nel corridoio di un pronto soccorso affollato. Durante la notte cominciarono a comparire dei termori in tutto il corpo. Arrivarono in tre per tenermi ferma e mi spararono in bocca una siringa con gocce di valium. Mi dissero che non avrei dovuto allattare per almeno un giorno e mi mandarono a casa con un foglietto su cui c’era scritto depressione post partum. Fu quello l’inizio di un lungo periodo difficile. Cominciai ad essere confusa, ad avere paure di tutti i tipi, a non essere più lucida. Dicevo e facevo cose strane. Non riuscivo ad accudire il mio piccolo e svuotavo il latte tirato nel lavandino perché il medico a cui i miei familiari si rivolsero cominciò a prescrivermi psicofarmaci che resero il latte un veleno per il mio cucciolo. Trascorsi un paio di settimane a casa e oltre un mese in un reparto di psichiatria. Fu un periodo strano. Da una parte mi mancava mio figlio e dall’altra ero contenta di essermi allontanata da lui e da tutti per ricomporre la mia mente in frantumi. In quel periodo emerse il meglio e il peggio di me, mischiati in un unico pentolone che ribolliva giorno e notte, senza darmi un attimo di tregua. Tornai a casa quando il mio bimbo aveva quasi due mesi. Aveva un odore che non riconoscevo, beveva un latte che non era il mio, piangeva quando lo tenevo in braccio e si calmava soltanto tra le braccia della nonna. Non sapevo cullarlo, non sapevo consolarlo, non sapevo essere la sua mamma. Gli volevo bene, tanto bene, ma la naturalezza del nostro rapporto aveva lasciato posto ad una voragine che mi sembrava incolmabile. Ci vollero mesi di duro lavoro per ritrovarci. Dopo quattro mesi smisi di prendere psicofarmaci e piano piano cominciammo lentamente ad annusarci, a coccolarci, a conoscerci. Dopo altri cinque mesi rimanemmo finalmente soli. Senza il papà che tornava soltano per il weekend e senza le nonne che tornarono a vivere nelle proprie case dopo mesi di convivenza forzata sotto le stesso tetto. Mi cominciai a sentire finalmente madre ma con la sensazione costante di dover dimostrare al mondo di poterlo essere. Non era scontato, non era facile. Inghiottivo ogni giorno dolore per trasformarlo in grinta, inventando modi sempre diversi per farmi amare dal mio cucciolo. Lentamente cominciai a non pensare più a quel periodo tanto difficile e ritornai ad essere la persona che ero ma con una sensibilità più accentuata. Passarono gli anni e dopo quattro io e mio marito decidemmo di avere un altro figlio che arrivò al secondo tentativo. Sentii la sua presenza dentro di me da quando vidi la seconda linea rossa sul test di gravidanza. Quel puntino dentro di me era già il mio secondo amore prima ancora che il suo cuore cominciasse a battere. Decisi subito di cambiare ginecologo e struttura ospedaliera, di azzerare il passato per costruire un nuovo futuro. La fortuna mi portò a bussare alla porta di un medico speciale che si accorse al primo sguardo che qualcosa andava ancora risolta prima di partorire il secondo figlio. Mi suggerì subito di rivolgermi ad uno psicologo e la mia prima reazione fu un mix di incredulità e rabbia. Che ne sapeva lui di me, della mia storia, della mia forza? Tornai a casa infastidita ma le sue parole aprirono un varco nelle mie insicurezze. Mi resi conto in pochi giorni che in quattro anni ero riuscita a tappare un buco nero con un velo di forza ma che il buco c’era ancora e che il velo era troppo sottile. Decisi di frantumare il velo e di tuffarmi nel buco nero con l’aiuto di un salvagente: una psicologa dagli occhi gentili e pieni di umanità. La perlustrazione del buco nero durò per tutta la gravidanza e anche per qualche mese dopo la nascita del mio secondo angelo dagli occhi color caffè. La mia bimba adesso ha quasi 8 mesi, vissuti in buona parte cuore a cuore dentro una fascia rosa o attaccata al mio seno da cui non esce più veleno ma amore. Il suo arrivo è stato un balsamo sulle ferite che avevano sanguinato senza sosta per 4 lunghi anni. Grazie a lei e con lei ho seminato fiori nel buco nero che adesso si è trasformato in un pozzo di esperienze, di emozioni, di vita. Ed è ancora grazie a lei che mi sono riappropriata della naturalezza del rapporto con il mio primo figlio, cominciando a coccolarlo e accudirlo con un trasporto nuovo, carico di tenerezza. Adesso non piango più pensando a quanto ho perso, perché ormai quasi tutto è stato recuperato. Non potrò più recupare la donna che ero prima del crollo: una donna che metteva al primo posto il lavoro, che non si guardava mai indietro, che faceva della razionalità il suo punto di forza. Quella donna ha lasciato posto a me: una persona imperfetta, una mamma felice, una donna forte.

 La psicologia perinatale riguarda tutti. Lo penso davvero e lo vivo ogni giorno nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dove lavoro e incontro neogenitori e cuccioli appena nati. Si, perché stare accanto alla mamma e al papà in un setting privilegiato come la sala parto o la sala operatoria mi conferma quotidianamente quanto sia nutriente l’accoglienza e il SAPER STARE un passo indietro per non intralciare il naturale processo della genitorialità, o il SAPER SOSTENERE, qualora ce ne fosse bisogno, attraverso la maieutica, le competenze genitoriali, patrimonio di cui spesso siamo portatori sani ma inconsapevoli.
La psicologia perinatale riguarda tutti. Lo penso davvero e lo vivo ogni giorno nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dove lavoro e incontro neogenitori e cuccioli appena nati. Si, perché stare accanto alla mamma e al papà in un setting privilegiato come la sala parto o la sala operatoria mi conferma quotidianamente quanto sia nutriente l’accoglienza e il SAPER STARE un passo indietro per non intralciare il naturale processo della genitorialità, o il SAPER SOSTENERE, qualora ce ne fosse bisogno, attraverso la maieutica, le competenze genitoriali, patrimonio di cui spesso siamo portatori sani ma inconsapevoli. Il disturbo bipolare. Che cos’è?
Il disturbo bipolare. Che cos’è? I tempi dell’attesa necessitano di uno spazio fisiologico per allinearsi nella mente e nel cuore della mamma e del papà, in un processo straordinario che racconta l’identità della coppia e i suoi bisogni. Compito di noi operatori è accogliere e favorire l’ascolto attivo attraverso gli incontri del PerCorso di Accompagnamento alla Nascita e alla Genitorialità, occasione elettiva per stimolare maggiore consapevolezza delle proprie competenze genitoriali, elemento necessario per “sostare in contatto” con le emozioni della gravidanza. Perché è nutriente “fare spazio” attraverso la narrazione e il confronto con le altre coppie in un luogo che non presenta spigoli ma curve morbide e accoglienti come le pance delle mamme dove tessere una rete di sostegno alla pari diventa una fisiologica necessità per ascoltarsi e ascoltare.
I tempi dell’attesa necessitano di uno spazio fisiologico per allinearsi nella mente e nel cuore della mamma e del papà, in un processo straordinario che racconta l’identità della coppia e i suoi bisogni. Compito di noi operatori è accogliere e favorire l’ascolto attivo attraverso gli incontri del PerCorso di Accompagnamento alla Nascita e alla Genitorialità, occasione elettiva per stimolare maggiore consapevolezza delle proprie competenze genitoriali, elemento necessario per “sostare in contatto” con le emozioni della gravidanza. Perché è nutriente “fare spazio” attraverso la narrazione e il confronto con le altre coppie in un luogo che non presenta spigoli ma curve morbide e accoglienti come le pance delle mamme dove tessere una rete di sostegno alla pari diventa una fisiologica necessità per ascoltarsi e ascoltare. Credo fermamente che il miglior modo di onorare una notte d’estate dall’aria rarefatta e sospesa, sia scrivere pensieri ribelli dall’ apnea densa e faticosa. E allora scrivo. E accolgo pensieri. Scrivo di storie di donne e di uomini che quotidianamente ascolto grazie al mio lavoro, raccolgo emozioni di vite vissute, sostengo fatiche di un quotidiano viversi, riunisco parti di Sé in frammenti. In una parola ASCOLTO (dentro), lasciando scorrere tutto questo attraverso un sistema osmotico di pieni e vuoti che solo anni di pratica clinica insegnano e consolidano in un quotidiano ripetersi di rituali per accogliere ed accogliersi.
Credo fermamente che il miglior modo di onorare una notte d’estate dall’aria rarefatta e sospesa, sia scrivere pensieri ribelli dall’ apnea densa e faticosa. E allora scrivo. E accolgo pensieri. Scrivo di storie di donne e di uomini che quotidianamente ascolto grazie al mio lavoro, raccolgo emozioni di vite vissute, sostengo fatiche di un quotidiano viversi, riunisco parti di Sé in frammenti. In una parola ASCOLTO (dentro), lasciando scorrere tutto questo attraverso un sistema osmotico di pieni e vuoti che solo anni di pratica clinica insegnano e consolidano in un quotidiano ripetersi di rituali per accogliere ed accogliersi.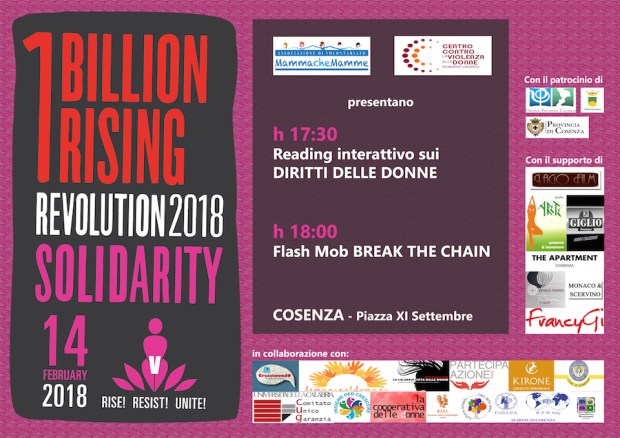
 Troppo spesso leggiamo articoli o libri che presentano l’intelligenza emotiva come la chiave di adattamento funzionale alla vita e ai suoi imprevisti. Una fitta rete di parole che descrive questo tipo di intelligenza, evidenziando le competenze individuali e sociali affinché ci sia equilibrio tra cuore e il cervello. Un paradosso solo apparente che invece sottolinea quanto sia necessario favorire l’espressione di tale intelligenza considerandola una funzione adattiva e protettiva della Persona. Essere emotivamente competenti significa conoscere consapevolmente le proprie emozioni, la loro intensità e l’effetto che provocano in se stess* e sugli altri.
Troppo spesso leggiamo articoli o libri che presentano l’intelligenza emotiva come la chiave di adattamento funzionale alla vita e ai suoi imprevisti. Una fitta rete di parole che descrive questo tipo di intelligenza, evidenziando le competenze individuali e sociali affinché ci sia equilibrio tra cuore e il cervello. Un paradosso solo apparente che invece sottolinea quanto sia necessario favorire l’espressione di tale intelligenza considerandola una funzione adattiva e protettiva della Persona. Essere emotivamente competenti significa conoscere consapevolmente le proprie emozioni, la loro intensità e l’effetto che provocano in se stess* e sugli altri.

 Il narcisismo è un tratto di personalità presente in ognuno di noi e utilizzato come difesa del proprio sé. In psicologia evolutiva il narcisismo è inteso come avere una prospettiva centrata su di sé, strategia naturale che permette al bambino di esprimere dolore fisico e disagio emotivo, soprattutto quando non ha ancora acquisito l’utilizzo del linguaggio. La capacità di riconoscere ed esprimere i propri bisogni piangendo, gli permette di ottenere l’accudimento necessario per sopravvivere. Alla luce di questo il narcisismo sano permette lo sviluppo di un attaccamento sicuro, sostenuto da una capacità adattiva di entrare in relazione con gli altri mantenendo la giusta distanza.
Il narcisismo è un tratto di personalità presente in ognuno di noi e utilizzato come difesa del proprio sé. In psicologia evolutiva il narcisismo è inteso come avere una prospettiva centrata su di sé, strategia naturale che permette al bambino di esprimere dolore fisico e disagio emotivo, soprattutto quando non ha ancora acquisito l’utilizzo del linguaggio. La capacità di riconoscere ed esprimere i propri bisogni piangendo, gli permette di ottenere l’accudimento necessario per sopravvivere. Alla luce di questo il narcisismo sano permette lo sviluppo di un attaccamento sicuro, sostenuto da una capacità adattiva di entrare in relazione con gli altri mantenendo la giusta distanza.